GLI ARTICOLI SU MONTEPIANO
Anno 1 - Numero 9
Tono Zancaro e gli altri
di Alessandro Garbasi
di Alessandro Garbasi
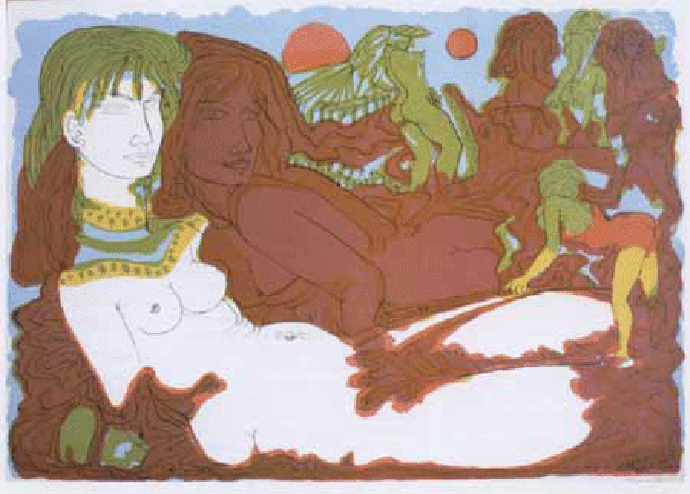
Limportante rassegna artistica è organizzata dal Comune di Neviano Arduini e dalla Pro Loca Val d'Enza (Parma), in collaborazione con l'Archivio Storico Tono Zancaro.
A lato:Le sirene di Ulisse 1974
Da quando ho iniziato a proporre mostre nel Centro Civico di Sella di Lodrignano, ormai tre anni fa, insieme al Comune di Neviano e alla Pro Loco Val d’Enza, abbiamo cercato di instaurare un dialogo con gli abitanti del territorio, soprattutto con quelli meno avvezzi a frequentare i luoghi dell’arte. Abbiamo allora provato a creare curiosità, e ridendo e scherzando anche un po’ di sana e sportiva rivalità.
Abbiamo invitato a esporre i pittori, gli scultori e i poeti del comune, indipendentemente che fossero professionisti o meno, in attività o non più viventi. Tramite un piccolo concorso riservato ai non professionisti, abbiamo cercato di chiudere il cerchio. Oltre alla giuria ufficiale, infatti, fin dalla prima edizione è stato istituito il premio del pubblico, con il duplice scopo di convincere anche i più scettici a partecipare (se non altro per fare un piacere a un amico!) e allo stesso tempo a partecipare in modo attivo e costruttivo, essendo tutti chiamati a osservare con attenzione le opere per esprimere una preferenza. Anche in vista di questa situazione, abbiamo voluto complicare le cose, almeno in apparenza: abbiamo lasciato che chiunque portasse il prodotto che voleva, senza le solite strazianti limitazioni di tema, tecnica e “stile”.
Nelle mostre di Sella si devono valutare contemporaneamente opere realizzate con le tecniche più diverse, astratte e figurative, grandi e piccole. Da subito abbiamo cercato di spiegare che tutte queste cose, in realtà, potevano convivere, e così, dopo un iniziale smarrimento, il pubblico ha risposto alla grande.
Il secondo passo è stato compiuto l’anno successivo. Ancora all’interno della mostra-concorso degli artisti Nevianesi, abbiamo aperto una finestra sull’esterno, rotto i confini comunali e mostrato al nostro pubblico qualcosa di diverso. La scelta è caduta su una nutrita personale di Francesca Bersani, pittrice piacentina (nonché responsabile dell’allestimento e co-curatrice insieme a me della mostra che presentiamo) che si stava preparando per partecipare alla Biennale di Roma.
Con lei il pubblico ha potuto prendere visione e familiarizzare, tra le altre cose, con le diverse tecniche di incisione, capitolo “in più” rispetto all’anno precedente. Acqueforti, puntesecche, acquetinte e xilografie, sono state presentate e spiegate, anche attraverso l’esposizione delle lastre originali e degli strumenti incisori.
Nelle mostre di Sella si devono valutare contemporaneamente opere realizzate con le tecniche più diverse, astratte e figurative, grandi e piccole. Da subito abbiamo cercato di spiegare che tutte queste cose, in realtà, potevano convivere, e così, dopo un iniziale smarrimento, il pubblico ha risposto alla grande.
Il secondo passo è stato compiuto l’anno successivo. Ancora all’interno della mostra-concorso degli artisti Nevianesi, abbiamo aperto una finestra sull’esterno, rotto i confini comunali e mostrato al nostro pubblico qualcosa di diverso. La scelta è caduta su una nutrita personale di Francesca Bersani, pittrice piacentina (nonché responsabile dell’allestimento e co-curatrice insieme a me della mostra che presentiamo) che si stava preparando per partecipare alla Biennale di Roma. Con lei il pubblico ha potuto prendere visione e familiarizzare, tra le altre cose, con le diverse tecniche di incisione, capitolo “in più” rispetto all’anno precedente. Acqueforti, puntesecche, acquetinte e xilografie, sono state presentate e spiegate, anche attraverso l’esposizione delle lastre originali e degli strumenti incisori.
Mancava solo il passo successivo, la presentazione, accanto ai locali, di un grande artista già consacrato.
Da qui la decisione di raccogliere dalle collezioni private Nevianesi le opere grafiche più interessanti di uno dei maggiori artisti italiani del XX secolo: Tono Zancanaro (Padova 1906-1985). Durante la sua carriera, l’artista patavino ha prodotto una quantità immensa di opere, e con una escursione di tecniche davvero incredibile. Dipingeva quadri classicamente intesi, disegnava tantissimo, incideva in cavo e in piano, sia su lastra che su vetro, realizzava e dipingeva ceramiche e sculture in terracotta, lavorava a mosaico, agli arazzi, con la fotografia, progettava costumi, scenografie teatrali e altro ancora. Un genio come il suo era l’ideale per coronare questo trittico di mostre a sfondo umilmente pedagogico. Infatti, nonostante i suoi lavori siano caratterizzati da figure eleganti e accattivanti, di quelle cioè, più vicine ai gusti del “Nostro” pubblico, il segno è spesso rapidissimo e scarabocchiato, tipico più degli artisti informali francesi dei primi tempi che non dei classici pittori della figura. Questo connubio tra linea sinuosa e isterica, che pone parte delle opere di Tono al limite tra l’alfabeto della forma e della non forma, giocava a favore del nostro discorso. Se prendiamo per esempio la litografia con la veduta di Venezia, e ci concentriamo sulle finestre della chiesa di San Giorgio Maggiore, ci accorgiamo che non sono altro che segni quasi amorfi, come quelli dell’arte “gestuale” (che purtroppo fa ancora tanto discutere nella tradizionalista montagna), e che li riconosciamo come finestre solo in virtù del loro contesto.
Ovviamente, nelle opere di Tono, si celano decine e decine di spunti di ragionamento, di chiavi di lettura e di allusioni colte. In mostra abbiamo cercato di metterne in luce solo alcune, per il miglior coinvolgimento del pubblico. Per questo, abbiamo pensato di invitare i visitatori a sostare a poca distanza dalle opere, per ricavarne spunti al di là di quelli suggeriti dai curatori. Con Tono, inoltre, aggiungiamo anche un tassello al nostro discorso sulle tecniche. In esposizione, infatti, si trova una sola incisione a puntasecca e acquaforte, mentre le altre sono tutte litografie, tecnica di stampa in piano che a Sella viene presentata per la prima volta. Lo scarso valore economico che le litografie hanno nella gerarchia delle arti, nulla toglie alla bellezza di questi fogli, che nella produzione dell’artista padovano non sono secondari.
Zancanaro, infatti, è uno dei maggiori artisti italiani nel campo della grafica (nel ‘52 vinse la Biennale di Venezia per l’incisione, e dal 1970 al ‘77 tenne la cattedra di incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna).
Ovviamente, nelle opere di Tono, si celano decine e decine di spunti di ragionamento, di chiavi di lettura e di allusioni colte. In mostra abbiamo cercato di metterne in luce solo alcune, per il miglior coinvolgimento del pubblico. Per questo, abbiamo pensato di invitare i visitatori a sostare a poca distanza dalle opere, per ricavarne spunti al di là di quelli suggeriti dai curatori. Con Tono, inoltre, aggiungiamo anche un tassello al nostro discorso sulle tecniche. In esposizione, infatti, si trova una sola incisione a puntasecca e acquaforte, mentre le altre sono tutte litografie, tecnica di stampa in piano che a Sella viene presentata per la prima volta. Lo scarso valore economico che le litografie hanno nella gerarchia delle arti, nulla toglie alla bellezza di questi fogli, che nella produzione dell’artista padovano non sono secondari. Zancanaro, infatti, è uno dei maggiori artisti italiani nel campo della grafica (nel ‘52 vinse la Biennale di Venezia per l’incisione, e dal 1970 al ‘77 tenne la cattedra di incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna). Di litografie poi, dal 1949 in avanti, ne realizzò migliaia, imponendosi come uno dei maggiori litografi esistiti. Le tematiche sono numerosissime. Volendo ridurre all’osso, possiamo dire che le satire antifasciste, quelle a sfondo polemico-politico, l’attenzione per i poveri e gli emarginati, la serie sulle grandi opere letterarie, e le tante immagini dedicate alle donne e ai luoghi da lui amati, sono una buona parte del suo lavoro.
Interessante l’unica incisione che presentiamo. Si intitola “Cono Nuzzo, caruso a Capo d’Orlando”. La storia è semplice. Tono si recava spesso in Sicilia, a Capo d’Orlando appunto. Amava dipingere i ragazzi, i carusi. Di loro lo affascinava la condizione efebica dei giovani maschi, ancora così femminili nei tratti, nella voce e nei modi. Cono Nuzzo aveva colpito Tono in modo particolare, e a lui dedicò diversi lavori. La cosa interessante è il volto di questo ragazzo, riconoscibile nella sua individualità, ma sempre più o meno lo stesso che l’artista utilizzava anche per altri soggetti. E’ come se Tono facesse talvolta indossare ai suoi modelli una maschera, e che affidasse l’identificazione dei personaggi ai versi aggiunti alle opere. La scrittura, infatti, occupa un capitolo intero nella biografia di Zancanaro: più o meno a partire dagli anni della serie del Gibbo, Tono completa le sue opere con numerose frasi, all’apparenza anche sconnesse, ma in realtà molto pungenti, ironiche e allusive, ispirate a fatti di cronaca o a quant’altro (Cese-Natico, si legge; e al centro della composizione un bel sedere di bagnante…). E in definitiva, la scelta di presentare gli attori dei suoi lavori con la “maschera”, corrisponde a quella di esprimersi sempre in modo criptico e allusivo, e in qualche modo potrebbe affondare le sue radici nella cultura artistica della giovinezza di Tono, quella Decò, dell’arte del c.d. Primitivismo e del Ventennio, che spesso proponevano volti senza orbite, simili appunto a maschere.
Infine, la scelta può forse rientrare anche nel dialogo che Tono aveva instaurato con l’arte antica, nella fattispecie quella teatrale. Diverse suggestioni stilistiche e iconografiche gli derivano infatti dalla pittura vascolare del mondo preromano, dall’arte romana e da quella orientale. A livello esemplificativo, in mostra viene proposto il confronto tra alcune immagini contenute nel “Carro di Santa Rosalia”, con altre tratte dai sarcofagi romani.
Oltre a Zancanaro, completano l’esposizione alcune grafiche di altri grandi artisti suoi amici: Augusto Murer, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Tonino Cortese, Remo Gaibazzi, Enzo Bioli e Sergio Vacchi.
Abbiamo invitato a esporre i pittori, gli scultori e i poeti del comune, indipendentemente che fossero professionisti o meno, in attività o non più viventi. Tramite un piccolo concorso riservato ai non professionisti, abbiamo cercato di chiudere il cerchio. Oltre alla giuria ufficiale, infatti, fin dalla prima edizione è stato istituito il premio del pubblico, con il duplice scopo di convincere anche i più scettici a partecipare (se non altro per fare un piacere a un amico!) e allo stesso tempo a partecipare in modo attivo e costruttivo, essendo tutti chiamati a osservare con attenzione le opere per esprimere una preferenza. Anche in vista di questa situazione, abbiamo voluto complicare le cose, almeno in apparenza: abbiamo lasciato che chiunque portasse il prodotto che voleva, senza le solite strazianti limitazioni di tema, tecnica e “stile”.
Nelle mostre di Sella si devono valutare contemporaneamente opere realizzate con le tecniche più diverse, astratte e figurative, grandi e piccole. Da subito abbiamo cercato di spiegare che tutte queste cose, in realtà, potevano convivere, e così, dopo un iniziale smarrimento, il pubblico ha risposto alla grande.
Il secondo passo è stato compiuto l’anno successivo. Ancora all’interno della mostra-concorso degli artisti Nevianesi, abbiamo aperto una finestra sull’esterno, rotto i confini comunali e mostrato al nostro pubblico qualcosa di diverso. La scelta è caduta su una nutrita personale di Francesca Bersani, pittrice piacentina (nonché responsabile dell’allestimento e co-curatrice insieme a me della mostra che presentiamo) che si stava preparando per partecipare alla Biennale di Roma.
Con lei il pubblico ha potuto prendere visione e familiarizzare, tra le altre cose, con le diverse tecniche di incisione, capitolo “in più” rispetto all’anno precedente. Acqueforti, puntesecche, acquetinte e xilografie, sono state presentate e spiegate, anche attraverso l’esposizione delle lastre originali e degli strumenti incisori.
Nelle mostre di Sella si devono valutare contemporaneamente opere realizzate con le tecniche più diverse, astratte e figurative, grandi e piccole. Da subito abbiamo cercato di spiegare che tutte queste cose, in realtà, potevano convivere, e così, dopo un iniziale smarrimento, il pubblico ha risposto alla grande.
Il secondo passo è stato compiuto l’anno successivo. Ancora all’interno della mostra-concorso degli artisti Nevianesi, abbiamo aperto una finestra sull’esterno, rotto i confini comunali e mostrato al nostro pubblico qualcosa di diverso. La scelta è caduta su una nutrita personale di Francesca Bersani, pittrice piacentina (nonché responsabile dell’allestimento e co-curatrice insieme a me della mostra che presentiamo) che si stava preparando per partecipare alla Biennale di Roma. Con lei il pubblico ha potuto prendere visione e familiarizzare, tra le altre cose, con le diverse tecniche di incisione, capitolo “in più” rispetto all’anno precedente. Acqueforti, puntesecche, acquetinte e xilografie, sono state presentate e spiegate, anche attraverso l’esposizione delle lastre originali e degli strumenti incisori.
Mancava solo il passo successivo, la presentazione, accanto ai locali, di un grande artista già consacrato.
Da qui la decisione di raccogliere dalle collezioni private Nevianesi le opere grafiche più interessanti di uno dei maggiori artisti italiani del XX secolo: Tono Zancanaro (Padova 1906-1985). Durante la sua carriera, l’artista patavino ha prodotto una quantità immensa di opere, e con una escursione di tecniche davvero incredibile. Dipingeva quadri classicamente intesi, disegnava tantissimo, incideva in cavo e in piano, sia su lastra che su vetro, realizzava e dipingeva ceramiche e sculture in terracotta, lavorava a mosaico, agli arazzi, con la fotografia, progettava costumi, scenografie teatrali e altro ancora. Un genio come il suo era l’ideale per coronare questo trittico di mostre a sfondo umilmente pedagogico. Infatti, nonostante i suoi lavori siano caratterizzati da figure eleganti e accattivanti, di quelle cioè, più vicine ai gusti del “Nostro” pubblico, il segno è spesso rapidissimo e scarabocchiato, tipico più degli artisti informali francesi dei primi tempi che non dei classici pittori della figura. Questo connubio tra linea sinuosa e isterica, che pone parte delle opere di Tono al limite tra l’alfabeto della forma e della non forma, giocava a favore del nostro discorso. Se prendiamo per esempio la litografia con la veduta di Venezia, e ci concentriamo sulle finestre della chiesa di San Giorgio Maggiore, ci accorgiamo che non sono altro che segni quasi amorfi, come quelli dell’arte “gestuale” (che purtroppo fa ancora tanto discutere nella tradizionalista montagna), e che li riconosciamo come finestre solo in virtù del loro contesto.
Ovviamente, nelle opere di Tono, si celano decine e decine di spunti di ragionamento, di chiavi di lettura e di allusioni colte. In mostra abbiamo cercato di metterne in luce solo alcune, per il miglior coinvolgimento del pubblico. Per questo, abbiamo pensato di invitare i visitatori a sostare a poca distanza dalle opere, per ricavarne spunti al di là di quelli suggeriti dai curatori. Con Tono, inoltre, aggiungiamo anche un tassello al nostro discorso sulle tecniche. In esposizione, infatti, si trova una sola incisione a puntasecca e acquaforte, mentre le altre sono tutte litografie, tecnica di stampa in piano che a Sella viene presentata per la prima volta. Lo scarso valore economico che le litografie hanno nella gerarchia delle arti, nulla toglie alla bellezza di questi fogli, che nella produzione dell’artista padovano non sono secondari.
Zancanaro, infatti, è uno dei maggiori artisti italiani nel campo della grafica (nel ‘52 vinse la Biennale di Venezia per l’incisione, e dal 1970 al ‘77 tenne la cattedra di incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna).
Ovviamente, nelle opere di Tono, si celano decine e decine di spunti di ragionamento, di chiavi di lettura e di allusioni colte. In mostra abbiamo cercato di metterne in luce solo alcune, per il miglior coinvolgimento del pubblico. Per questo, abbiamo pensato di invitare i visitatori a sostare a poca distanza dalle opere, per ricavarne spunti al di là di quelli suggeriti dai curatori. Con Tono, inoltre, aggiungiamo anche un tassello al nostro discorso sulle tecniche. In esposizione, infatti, si trova una sola incisione a puntasecca e acquaforte, mentre le altre sono tutte litografie, tecnica di stampa in piano che a Sella viene presentata per la prima volta. Lo scarso valore economico che le litografie hanno nella gerarchia delle arti, nulla toglie alla bellezza di questi fogli, che nella produzione dell’artista padovano non sono secondari. Zancanaro, infatti, è uno dei maggiori artisti italiani nel campo della grafica (nel ‘52 vinse la Biennale di Venezia per l’incisione, e dal 1970 al ‘77 tenne la cattedra di incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna). Di litografie poi, dal 1949 in avanti, ne realizzò migliaia, imponendosi come uno dei maggiori litografi esistiti. Le tematiche sono numerosissime. Volendo ridurre all’osso, possiamo dire che le satire antifasciste, quelle a sfondo polemico-politico, l’attenzione per i poveri e gli emarginati, la serie sulle grandi opere letterarie, e le tante immagini dedicate alle donne e ai luoghi da lui amati, sono una buona parte del suo lavoro.
Interessante l’unica incisione che presentiamo. Si intitola “Cono Nuzzo, caruso a Capo d’Orlando”. La storia è semplice. Tono si recava spesso in Sicilia, a Capo d’Orlando appunto. Amava dipingere i ragazzi, i carusi. Di loro lo affascinava la condizione efebica dei giovani maschi, ancora così femminili nei tratti, nella voce e nei modi. Cono Nuzzo aveva colpito Tono in modo particolare, e a lui dedicò diversi lavori. La cosa interessante è il volto di questo ragazzo, riconoscibile nella sua individualità, ma sempre più o meno lo stesso che l’artista utilizzava anche per altri soggetti. E’ come se Tono facesse talvolta indossare ai suoi modelli una maschera, e che affidasse l’identificazione dei personaggi ai versi aggiunti alle opere. La scrittura, infatti, occupa un capitolo intero nella biografia di Zancanaro: più o meno a partire dagli anni della serie del Gibbo, Tono completa le sue opere con numerose frasi, all’apparenza anche sconnesse, ma in realtà molto pungenti, ironiche e allusive, ispirate a fatti di cronaca o a quant’altro (Cese-Natico, si legge; e al centro della composizione un bel sedere di bagnante…). E in definitiva, la scelta di presentare gli attori dei suoi lavori con la “maschera”, corrisponde a quella di esprimersi sempre in modo criptico e allusivo, e in qualche modo potrebbe affondare le sue radici nella cultura artistica della giovinezza di Tono, quella Decò, dell’arte del c.d. Primitivismo e del Ventennio, che spesso proponevano volti senza orbite, simili appunto a maschere.
Infine, la scelta può forse rientrare anche nel dialogo che Tono aveva instaurato con l’arte antica, nella fattispecie quella teatrale. Diverse suggestioni stilistiche e iconografiche gli derivano infatti dalla pittura vascolare del mondo preromano, dall’arte romana e da quella orientale. A livello esemplificativo, in mostra viene proposto il confronto tra alcune immagini contenute nel “Carro di Santa Rosalia”, con altre tratte dai sarcofagi romani.
Oltre a Zancanaro, completano l’esposizione alcune grafiche di altri grandi artisti suoi amici: Augusto Murer, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Tonino Cortese, Remo Gaibazzi, Enzo Bioli e Sergio Vacchi.
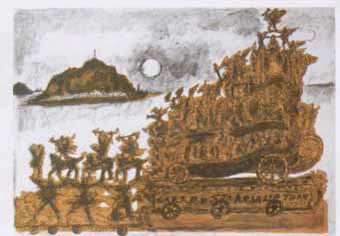
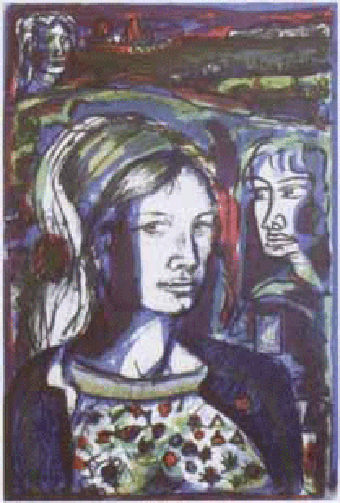

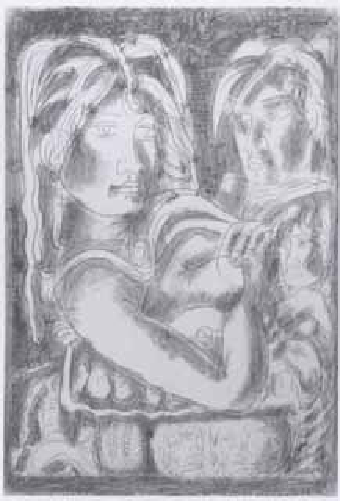
Carro di Santa Rosalia, 1974
Luisa, 1967
Veduta di Venezia, non datata, attribuibile al 1970 circa
L'oca badessa, l'anatra contessa, 1969