GLI ARTICOLI SU MONTEPIANO
Anno 6° - Numero 59
9 FEBBRAIO 1945: ECCIDIO DI VILLA CADÈ
Tra le vittime, i nevianesi Silvio Monica e Marcello Cavazzini di 16 e 15 anni
di Mario Rinaldi
Tra le vittime, i nevianesi Silvio Monica e Marcello Cavazzini di 16 e 15 anni
di Mario Rinaldi
Silvio Monica, di Neviano, aveva sedici anni quando i tedeschi lo catturarono e sarebbe stato solo un ragazzo se non ci fosse stata la guerra.
Era entrato nella Resistenza in modo marginale, con compiti di vigllanza, di nascosto dalla famiglia, e di tanto in tanto, di sera, faceva turni di guardia comandato dalla locale 178° SAP. Per la sua giovane età, e in quanto del posto, non riteneva di dover entrare in un Distaccamento per il rapporto che gli era obbligo mantenere con la famiglia (i suoi erano contadini) essendo lui l'unico di tre fratelli che potesse dare una mano nel lavoro dei campi.
Il 31 gennaio 1945, come in tante altre sere di quell'inverno pieno di neve, Silvio lo avevano mandato a fare la guardia sulla curva del Molino, nel tratto finale dei tornanti che cominciano all'Isolanda, in fondo aProvazzano, e che poi, dopo tre chilometri, arrivano a Neviano. Con lui era il cugino Marcello Cavazzini, di Parma, quindici anni, da qualche tempo sfollato a Quinzano, vicino alla casa di Silvio. Ancora oggi sono in molti quelli che si chiedono come sia stata possibile la loro cattura. Così andarono i fatti: Silvio e Marcello, come già detto, si erano appostati sulla curva del Molino, punto strategico, da dove potevano tener d'occhio i tornanti fin oltre
i tetti di Quinzano.
Il posto era più che sicuro perché dal quel punto nulla che si muovesse sulla strada poteva sfuggire alla loro osservazione, anche fuori dalla strada. E c'era una luna che quasi sembrava giorno. A una cert'ora, prima di mezzanotte, in fondo all'Isolanda i bagliori di un bengala illuminarono la campagna e poco dopo una fila scura di gente in movimento cominciò a stagliarsi nel piano del cimitero, appena sopra a Provazzano.
Che fossero tedeschi non c'era dubbio ma Silvio e Marcello non persero la calma perché l'abbondante strato della neve e la composizione stessa della colonna (c'erano muli e cavalli) dava loro la certezza che nessuno quella sera avrebbe potuto muoversi fuori dalla strada senza la certezza di non essere individuato. Né lui né Marcello erano esperti di cose militari ma in quel tempo anche i bambini erano in grado di capire certe cose. In altri termini: non era necessario l'orologio per calcolare il tempo che la colonna avrebbe impiegato per salire fino al tornante del Molino. Tutto sotto controllo, quindi. Si trattava di una delle ricorrenti puntate naziste e a giudizio dei due cuginetti il tempo a loro disposizione per retrocedere fino al bivio del Banzuolo, alcune centinaia di metri più in alto, per poi andare ad avvertire i compagni che erano a dormire dalle parti di Case Bottini, c'era tutto e anche ne avanzava. Loro, poi, fatto il giro di Case Bottini, sarebbero scesi a Quinzano, alle spalle della colonna, e la loro missione sarebbe stata compiuta. I loro calcoli non avevano però previsto quello che da lì a poco sarebbe successo. I tedeschi, infatti, sapendo di essere visibili anche a distanza, attuarono uno stratagemma che quella notte fu fatale non solo a Silvio e a Marcello ma anche a tutti quei partigiani che fino a Scurano si fossero trovati sulla strada a fare turni di guardia. E mentre i due cugini ripiegavano con calma verso il bivio del Banzuolo che poi andavano a dormire a casa loro, si videro addosso, senza rendersene conto, alcuni uomini che si erano staccati dalla colonna e che erano saliti senza farsi notare col preciso obiettivo di colpire a sorpresa. Erano uomini vestiti di bianco che col paesaggio facevano tutt'uno. A proteggerli, se così si può dire, era il vociare sostenuto della colonna che più in basso di due chilometri saliva con calma per arrivare a Neviano.
Sarà lo stesso Silvio, durante il trasferimento verso Scurano, amman?ttato, a raccontare ad Alcide Monica come andarono i fatti. Alcide Monica era un giovane contadino di Neviano che i tedeschi avevano obbligato ad attaccare un brosso con due vacche per trasportare quel loro camerata che Silvio aveva colpito alle natiche con un colpo di pistola nel momento stesso in cui si era sentito intimare l'alt, appena oltre il Molino, e prima ancora di mettersi a scappare nei campi delle Piane.
A Neviano la colonna arrivò che era quasi mezzanotte con la gente del paese bloccata nei loro letti e dove di tanto in tanto secche raffiche di mitragliatrice facevano tremare il buio tutt'attorno. Mentre tutto questo succedeva la pattuglia "dei vestiti di bianco" ripartiva verso l'alto e a Case Campanari, appena un chilometro fuori Neviano, feriva gravemente Cipriano Sassi, un contadino che aveva preferito tentare la fuga piuttosto che rimanere chiuso in casa dove nessuno lo avrebbe toccato se non si fosse mosso (questo è il senno di poi). La sua figura che la luna stagliava sul bianco dei campi fu un facile bersaglio per quelli della pattuglia che gli spararono dalla strada. Il grosso della colonna, coi muli e coi cavalli, seguì poco dopo. Passata un'ora, al bivio per la pieve di Sasso, a essere sorpresi furono altri due partigiani. Lo scontro fu rapido e violento ma la sorpresa fu fatale a Freccia, partigiano della 144° Brigata Garibaldi reggiana. Il suo compagno si salvò buttandosi nel bosco.
La presenza in quella parte del nevianese di due partigiani della Brigata reggiana, messi lì a fare la guardia, conferma, come dice un documento
Era entrato nella Resistenza in modo marginale, con compiti di vigllanza, di nascosto dalla famiglia, e di tanto in tanto, di sera, faceva turni di guardia comandato dalla locale 178° SAP. Per la sua giovane età, e in quanto del posto, non riteneva di dover entrare in un Distaccamento per il rapporto che gli era obbligo mantenere con la famiglia (i suoi erano contadini) essendo lui l'unico di tre fratelli che potesse dare una mano nel lavoro dei campi.
Il 31 gennaio 1945, come in tante altre sere di quell'inverno pieno di neve, Silvio lo avevano mandato a fare la guardia sulla curva del Molino, nel tratto finale dei tornanti che cominciano all'Isolanda, in fondo aProvazzano, e che poi, dopo tre chilometri, arrivano a Neviano. Con lui era il cugino Marcello Cavazzini, di Parma, quindici anni, da qualche tempo sfollato a Quinzano, vicino alla casa di Silvio. Ancora oggi sono in molti quelli che si chiedono come sia stata possibile la loro cattura. Così andarono i fatti: Silvio e Marcello, come già detto, si erano appostati sulla curva del Molino, punto strategico, da dove potevano tener d'occhio i tornanti fin oltre
i tetti di Quinzano.
Il posto era più che sicuro perché dal quel punto nulla che si muovesse sulla strada poteva sfuggire alla loro osservazione, anche fuori dalla strada. E c'era una luna che quasi sembrava giorno. A una cert'ora, prima di mezzanotte, in fondo all'Isolanda i bagliori di un bengala illuminarono la campagna e poco dopo una fila scura di gente in movimento cominciò a stagliarsi nel piano del cimitero, appena sopra a Provazzano.
Che fossero tedeschi non c'era dubbio ma Silvio e Marcello non persero la calma perché l'abbondante strato della neve e la composizione stessa della colonna (c'erano muli e cavalli) dava loro la certezza che nessuno quella sera avrebbe potuto muoversi fuori dalla strada senza la certezza di non essere individuato. Né lui né Marcello erano esperti di cose militari ma in quel tempo anche i bambini erano in grado di capire certe cose. In altri termini: non era necessario l'orologio per calcolare il tempo che la colonna avrebbe impiegato per salire fino al tornante del Molino. Tutto sotto controllo, quindi. Si trattava di una delle ricorrenti puntate naziste e a giudizio dei due cuginetti il tempo a loro disposizione per retrocedere fino al bivio del Banzuolo, alcune centinaia di metri più in alto, per poi andare ad avvertire i compagni che erano a dormire dalle parti di Case Bottini, c'era tutto e anche ne avanzava. Loro, poi, fatto il giro di Case Bottini, sarebbero scesi a Quinzano, alle spalle della colonna, e la loro missione sarebbe stata compiuta. I loro calcoli non avevano però previsto quello che da lì a poco sarebbe successo. I tedeschi, infatti, sapendo di essere visibili anche a distanza, attuarono uno stratagemma che quella notte fu fatale non solo a Silvio e a Marcello ma anche a tutti quei partigiani che fino a Scurano si fossero trovati sulla strada a fare turni di guardia. E mentre i due cugini ripiegavano con calma verso il bivio del Banzuolo che poi andavano a dormire a casa loro, si videro addosso, senza rendersene conto, alcuni uomini che si erano staccati dalla colonna e che erano saliti senza farsi notare col preciso obiettivo di colpire a sorpresa. Erano uomini vestiti di bianco che col paesaggio facevano tutt'uno. A proteggerli, se così si può dire, era il vociare sostenuto della colonna che più in basso di due chilometri saliva con calma per arrivare a Neviano.
Sarà lo stesso Silvio, durante il trasferimento verso Scurano, amman?ttato, a raccontare ad Alcide Monica come andarono i fatti. Alcide Monica era un giovane contadino di Neviano che i tedeschi avevano obbligato ad attaccare un brosso con due vacche per trasportare quel loro camerata che Silvio aveva colpito alle natiche con un colpo di pistola nel momento stesso in cui si era sentito intimare l'alt, appena oltre il Molino, e prima ancora di mettersi a scappare nei campi delle Piane.
A Neviano la colonna arrivò che era quasi mezzanotte con la gente del paese bloccata nei loro letti e dove di tanto in tanto secche raffiche di mitragliatrice facevano tremare il buio tutt'attorno. Mentre tutto questo succedeva la pattuglia "dei vestiti di bianco" ripartiva verso l'alto e a Case Campanari, appena un chilometro fuori Neviano, feriva gravemente Cipriano Sassi, un contadino che aveva preferito tentare la fuga piuttosto che rimanere chiuso in casa dove nessuno lo avrebbe toccato se non si fosse mosso (questo è il senno di poi). La sua figura che la luna stagliava sul bianco dei campi fu un facile bersaglio per quelli della pattuglia che gli spararono dalla strada. Il grosso della colonna, coi muli e coi cavalli, seguì poco dopo. Passata un'ora, al bivio per la pieve di Sasso, a essere sorpresi furono altri due partigiani. Lo scontro fu rapido e violento ma la sorpresa fu fatale a Freccia, partigiano della 144° Brigata Garibaldi reggiana. Il suo compagno si salvò buttandosi nel bosco.
La presenza in quella parte del nevianese di due partigiani della Brigata reggiana, messi lì a fare la guardia, conferma, come dice un documento
inviato qualche giorno prima dalla città alle formazioni del nevianese, che nella zona di Scurano si era rifugiato il Comando Unico Reggiano e che proprio quello sarebbe stato l'unico obiettivo di una futura puntata nazista. Poi la pattuglia proseguì verso Scurano e alle prime case del paese sorprese una postazione partigiana che era in allerta per il gran baccano che la colonna faceva in alto, nella zona dell'Ariolla. La postazione era del Distaccamento Don Pasquino che quando si vide di fronte gli uomini vestiti di bianco aprì il fuoco immediatamente e in quello scontro cadde Renè, partigiano della 47° Brigata Garibaldi. Lo stesso fatto di Renè è stato raccontato in modo dettagliato da Guerra nel numero di gennaio di questa rivista.
I1 Distaccamento di Guerra, però, per raggiungere Scurano dovette seguire un altro percorso senza passare da Neviano. Il trucco nazista aveva così funzionato fino in fondo e poco dopo, ormai era l'alba, la colonna salita da Neviano si congiungeva nella piazza di Scurano con altre due formazioni che erano passare da Bazzano, da Cedogno e anche da Ceretolo. (Questo lo racconta Guerra). I prigionieri erano diversi e la luce del giorno dava un volto alla fisionomia di molti di quei militari: erano mongoli. Così, all'alba del 1° febbraio, terminò la terribile puntata nazista che, è bene dirlo, non fu un rastrellamento. Quella notte i tedeschi, in tutto il loro percorso, mai bussarono a una casa e mai uscirono di strada. Dunque, Silvio e Marcello avevano pensato giusto.
A Scurano le tre colonne rimasero fino al mattino del giorno dopo, quando una parte di loro si mise in marcia verso Langhirano salendo da Urzano e passando da San Michele Cavana dove catturò il partigiano Slim della 47° Garibaldl e in serata, per rappresaglia, siccome qualcuno aveva sparato, trucidò due civili catturati nei pressi del ponte in località Fienile. Ma torniamo al 1° febbraio. Era ormai mezza mattina quando Silvio, Marcello e diversi altri prigionieri furono messi in fila e fatti scendere verso l'Enza con destinazione Ciano dove il carcere li attendeva. Poi, passati dieci giorni, nella notte del 9 febbraio (erano le tre) una guardia con una lista in mano li chiamò per nome e li invitò a seguirla. (Il testimone di questo particolare è Vittorio Cavalli, di Cedogno, quello dei lucchetti, che anche lui era stato fatto prigioniero la notte del 31 gennaio e che a Ciano l'avevano messo a dormire nello stesso stanzone? di Silvio e Marcello). La guardia li fece poi salire
su un camion. Con loro c'erano anche Slim e anche Spumino, catturato aBazzano il mattino del 5 gennaio.
Li portarono a Villa Cadè dove, sulla via Emilia, un'ora dopo, li fucilarono tutti assieme. Erano ventuno.
Era un mattino freddo, molti gradi sotto lo zero, e sulle piante la nebbia era ghiacciata. I corpi di quei ventun martiri furono poi lasciati sul ciglio della strada per tre giorni e tre notti affinché chiunque potesse vederli quando passava. Il freddo li conservava.
Era una consuetudine, per i nazisti, esporre le loro vittime con lo scopo di aggiungere terrore a terrore.
Al terzo giorno la rimozione dei corpi fu autorizzara e a ospitare tutti fu il cimitero della parrocchia di san Pellegrino, a Reggio Emilia.
Ad occuparsene fu il parroco, che curò personalmente la tumulazione di ognuno con la preoccupazione del fatto che un giorno qualcuno sarebbe venuto a cercarli e anche per il fatto che nessuno aveva un documento in tasca.
Ritagliò quindi dalla giacca di tutti, o dalla camicia, un pezzo di stoffa che poi fissò su ogni singola bara e a ognuna delle salme appose un numero, lo stesso che mise sulle singole bare. Quindi fotografò le salme ognuna col numero sopra. Solo a guerra finita cominciò l'angoscioso peregrinare delle madri dei due cuginetti chè dalla notte del 31 gennaio nessuna notizia era arrivata a casa loro. Il loro muoversi a tastoni fu una via crucis quotidiana con viaggi a Parma, a Piacenza e ovunque si sentisse dire che là c'era stata una strage o un'esecuzione, e tutto coi mezzi di allora, anche a piedi.
A primavera inoltrata, era il 28 maggio, sulla base di notizie sempre più probabili, le due povere donne arrivarono alla parrocchia di San Pellegrino di Reggio dove il parroco mostrò le piccole cose che con ordine certosino aveva conservate. Silvio e Marcello furono così identificati. La salma di Silvio aveva il numero 3, quella di Marcello il numero 6, quella di Spumino il numero 1 e quella di Slim il numero 16. Le mani di tutti e quattro erano legate sulla schiena con un filo di ferro.
Il 14 giugno Silvio fu sepolto nel cimitero di Neviano accompagnato da un funerale imponente. Marcello fu sepolto invece a Parma, dove la sua famiglia era tornata ad abitare.
I1 Distaccamento di Guerra, però, per raggiungere Scurano dovette seguire un altro percorso senza passare da Neviano. Il trucco nazista aveva così funzionato fino in fondo e poco dopo, ormai era l'alba, la colonna salita da Neviano si congiungeva nella piazza di Scurano con altre due formazioni che erano passare da Bazzano, da Cedogno e anche da Ceretolo. (Questo lo racconta Guerra). I prigionieri erano diversi e la luce del giorno dava un volto alla fisionomia di molti di quei militari: erano mongoli. Così, all'alba del 1° febbraio, terminò la terribile puntata nazista che, è bene dirlo, non fu un rastrellamento. Quella notte i tedeschi, in tutto il loro percorso, mai bussarono a una casa e mai uscirono di strada. Dunque, Silvio e Marcello avevano pensato giusto.
A Scurano le tre colonne rimasero fino al mattino del giorno dopo, quando una parte di loro si mise in marcia verso Langhirano salendo da Urzano e passando da San Michele Cavana dove catturò il partigiano Slim della 47° Garibaldl e in serata, per rappresaglia, siccome qualcuno aveva sparato, trucidò due civili catturati nei pressi del ponte in località Fienile. Ma torniamo al 1° febbraio. Era ormai mezza mattina quando Silvio, Marcello e diversi altri prigionieri furono messi in fila e fatti scendere verso l'Enza con destinazione Ciano dove il carcere li attendeva. Poi, passati dieci giorni, nella notte del 9 febbraio (erano le tre) una guardia con una lista in mano li chiamò per nome e li invitò a seguirla. (Il testimone di questo particolare è Vittorio Cavalli, di Cedogno, quello dei lucchetti, che anche lui era stato fatto prigioniero la notte del 31 gennaio e che a Ciano l'avevano messo a dormire nello stesso stanzone? di Silvio e Marcello). La guardia li fece poi salire
su un camion. Con loro c'erano anche Slim e anche Spumino, catturato aBazzano il mattino del 5 gennaio.
Li portarono a Villa Cadè dove, sulla via Emilia, un'ora dopo, li fucilarono tutti assieme. Erano ventuno.
Era un mattino freddo, molti gradi sotto lo zero, e sulle piante la nebbia era ghiacciata. I corpi di quei ventun martiri furono poi lasciati sul ciglio della strada per tre giorni e tre notti affinché chiunque potesse vederli quando passava. Il freddo li conservava.
Era una consuetudine, per i nazisti, esporre le loro vittime con lo scopo di aggiungere terrore a terrore.
Al terzo giorno la rimozione dei corpi fu autorizzara e a ospitare tutti fu il cimitero della parrocchia di san Pellegrino, a Reggio Emilia.
Ad occuparsene fu il parroco, che curò personalmente la tumulazione di ognuno con la preoccupazione del fatto che un giorno qualcuno sarebbe venuto a cercarli e anche per il fatto che nessuno aveva un documento in tasca.
Ritagliò quindi dalla giacca di tutti, o dalla camicia, un pezzo di stoffa che poi fissò su ogni singola bara e a ognuna delle salme appose un numero, lo stesso che mise sulle singole bare. Quindi fotografò le salme ognuna col numero sopra. Solo a guerra finita cominciò l'angoscioso peregrinare delle madri dei due cuginetti chè dalla notte del 31 gennaio nessuna notizia era arrivata a casa loro. Il loro muoversi a tastoni fu una via crucis quotidiana con viaggi a Parma, a Piacenza e ovunque si sentisse dire che là c'era stata una strage o un'esecuzione, e tutto coi mezzi di allora, anche a piedi.
A primavera inoltrata, era il 28 maggio, sulla base di notizie sempre più probabili, le due povere donne arrivarono alla parrocchia di San Pellegrino di Reggio dove il parroco mostrò le piccole cose che con ordine certosino aveva conservate. Silvio e Marcello furono così identificati. La salma di Silvio aveva il numero 3, quella di Marcello il numero 6, quella di Spumino il numero 1 e quella di Slim il numero 16. Le mani di tutti e quattro erano legate sulla schiena con un filo di ferro.
Il 14 giugno Silvio fu sepolto nel cimitero di Neviano accompagnato da un funerale imponente. Marcello fu sepolto invece a Parma, dove la sua famiglia era tornata ad abitare.
Il professor Mario Rinaldi.
"E c'era una luna che quasi sembrava giorno. A una cert'ora, prima di mezzanotte, in fondo all'Isolanda i bagliori di un bengala illuminarono la campagna e poco dopo una fila scura di gente in movimento cominciò a stagliarsi nel piano del cimitero, appena sopra a Provazzano".
Scrittore e storico della Resistenza, Mario Rinaldi è scomparso il 1° dicembre scorso, lasciando un profondo vuoto nella comunità e nella cultura. Nato a Neviano degli Arduini 77 anni fa, era stato per molti anni insegnante negli Istituti superiori di Reggio Emilia e di Parma e consigliere comunale a Neviano dove, per un mandato amministrativo, ha ricoperto anche l'incarico di vice sindaco. Oltre al saggio Dal Ventasso al Fuso (1988), ha scritto il romanzo Boogie Woogie (2002) sempre ambientato nel periodo della Resistenza. Nel 2008 ha curato, con Giuseppe Massari, l'antologia Vento del Nord. Aveva in fase di avanzata stesura un nuovo romanzo.

In alto: Ubaldo Bertoli, Puntata nazista su Scurano.

Silvio Monica
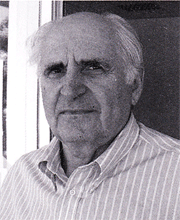
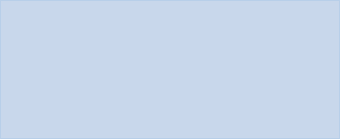
Spumino (MircoAndreoli di Parma. Medaglia d'oro al Valor Militare).
Slim (Antonio Schiavi di Langhirano).
Freccía (Celso Benassi di Monzuno, in provincia di Bologna).
Slim (Antonio Schiavi di Langhirano).
Freccía (Celso Benassi di Monzuno, in provincia di Bologna).
"Il 9 febbraio del 1945 a Villa Cadè, sulla via Emilia, vengono fucilati per rappresaglia 21 ostaggi prigionieri del nazisti a Ciano e a Reggio...
I corpi di quei ventun martiri furono poi lasciati sul ciglio della strada per tre giorni e tre notti affinché chiunque potesse vederli quando passava".
I corpi di quei ventun martiri furono poi lasciati sul ciglio della strada per tre giorni e tre notti affinché chiunque potesse vederli quando passava".