GLI ARTICOLI SU MONTEPIANO
Anno 1 - Numero 5
Il Fonte Battesimale di Bazzano
di Alessandro Garbasi
di Alessandro Garbasi

Ci sono luoghi nell’Appennino Parmense solitari e taciturni, che hanno una dimensione solo all’interno del loro piccolo contesto. Bazzano è uno di questi, tra i maggiori centri del comune di Neviano degli Arduini, sorge a cavallo del crinale che divide le vallate dell’Enza e della Termina di Castione. Gioiello della località Nevianese è senza dubbio il fonte battesimale della Pieve di Sant’Ambrogio, uno dei pezzi medievali più interessanti e meno noti di tutta la Provincia.
Si tratta di un monoblocco calcareo di forma ottagonale all’esterno e troncoconica all’interno, scolpito su ogni lato con figure inquadrate da colonne angolari e da archi decorati con motivi vegetali. La scansione architettonica “a loggia” deriva forse dai sarcofagi romani: il fonte battesimale è infatti associato simbolicamente al sepolcro nel quale il fedele, tramite il Battesimo, depone la vita vecchia condizionata dal Peccato Originale per rinascere puro, nel seno della comunità cristiana; naturalmente il riferimento è alla morte e alla Resurrezione di Cristo, che proprio nel sepolcro aveva sconfitto la morte.
San Giovanni Battista, Cristo benedicente con il libro, l’Albero della Vita con le colombe e l’ampolla, l’Arcangelo Gabriele, l’Agnello che porta la croce, un personaggio maschile (probabilmente il catecumeno, cioè chi si prepara per ricevere il Battesimo), il Leone e la Vergine sono le immagini significanti. La chiave di lettura si svela a partire dal personaggio principale: Giovanni Battista (riconoscibile dall’aureola, dai piedi scalzi e dalla tipologia della cintura) in qualità di battezzatore di Cristo e dedicatario dei fonti battesimali è infatti incorniciato con due colonne scanalate, le uniche del fonte a non essere lisce (per inciso questo particolare indica come l’attuale orientamento della vasca, che privilegia il lato della Vergine, non sia del tutto corretto). Giovanni alza la mano sinistra con gesto oratorio e di saluto, quasi stesse recitando la sua frase più famosa: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv. 1, 29). In effetti, sullo stesso asse dall’altra parte dell’ottagono, è rappresentato proprio l’Agnello crucifero, simbolo del martirio di Cristo e attributo del Battista. Applicando questo sistema di lettura per “contrapposizioni”, suggerito dalla trama dei gesti, anche alle altre immagini (vd. disegno), si scopre per esempio che la Vergine sta portando la mano all’orecchio per ascoltare l’annuncio dell’Angelo scolpito sul lato opposto del fonte (episodio dell’Annunciazione). Allo stesso modo al Cristo benedicente (identificato dall’aureola crucigera) corrisponde il catecumeno: certamente non casuale è la mancanza di azione che caratterizza questa figura, “mancanza” in realtà funzionale a mettere in evidenza la sua condizione ricettiva (sottolineata dalle orecchie - vd. foto) nei confronti delle parole di Cristo, forse un tempo dipinte sulle pagine del libro. Al leone, che tra le fauci stringe probabilmente un cartiglio (vd. foto), si contrappongono invece l’Albero della Vita e le colombe con l’ampolla, due modi per alludere alla resurrezione rispettivamente di Cristo e dei fedeli.
Gli incroci delineati non escludono tuttavia anche una lettura consequenziale di alcune parti, come sembra suggerire la giustapposizione della Vergine, del Battista e di Cristo, che fanno visivamente gruppo grazie al moltiplicarsi del gesto e alla presenza delle aureole, esclusiva di queste tre figure.
Stabilito che la chiave di lettura risiede nel codice gestuale, ecco spiegato come mai le forme siano così elementari, le mani così lunghe e le braccia così sproporzionate, caratteristiche tipiche di un
Si tratta di un monoblocco calcareo di forma ottagonale all’esterno e troncoconica all’interno, scolpito su ogni lato con figure inquadrate da colonne angolari e da archi decorati con motivi vegetali. La scansione architettonica “a loggia” deriva forse dai sarcofagi romani: il fonte battesimale è infatti associato simbolicamente al sepolcro nel quale il fedele, tramite il Battesimo, depone la vita vecchia condizionata dal Peccato Originale per rinascere puro, nel seno della comunità cristiana; naturalmente il riferimento è alla morte e alla Resurrezione di Cristo, che proprio nel sepolcro aveva sconfitto la morte.
San Giovanni Battista, Cristo benedicente con il libro, l’Albero della Vita con le colombe e l’ampolla, l’Arcangelo Gabriele, l’Agnello che porta la croce, un personaggio maschile (probabilmente il catecumeno, cioè chi si prepara per ricevere il Battesimo), il Leone e la Vergine sono le immagini significanti. La chiave di lettura si svela a partire dal personaggio principale: Giovanni Battista (riconoscibile dall’aureola, dai piedi scalzi e dalla tipologia della cintura) in qualità di battezzatore di Cristo e dedicatario dei fonti battesimali è infatti incorniciato con due colonne scanalate, le uniche del fonte a non essere lisce (per inciso questo particolare indica come l’attuale orientamento della vasca, che privilegia il lato della Vergine, non sia del tutto corretto). Giovanni alza la mano sinistra con gesto oratorio e di saluto, quasi stesse recitando la sua frase più famosa: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv. 1, 29). In effetti, sullo stesso asse dall’altra parte dell’ottagono, è rappresentato proprio l’Agnello crucifero, simbolo del martirio di Cristo e attributo del Battista. Applicando questo sistema di lettura per “contrapposizioni”, suggerito dalla trama dei gesti, anche alle altre immagini (vd. disegno), si scopre per esempio che la Vergine sta portando la mano all’orecchio per ascoltare l’annuncio dell’Angelo scolpito sul lato opposto del fonte (episodio dell’Annunciazione). Allo stesso modo al Cristo benedicente (identificato dall’aureola crucigera) corrisponde il catecumeno: certamente non casuale è la mancanza di azione che caratterizza questa figura, “mancanza” in realtà funzionale a mettere in evidenza la sua condizione ricettiva (sottolineata dalle orecchie - vd. foto) nei confronti delle parole di Cristo, forse un tempo dipinte sulle pagine del libro. Al leone, che tra le fauci stringe probabilmente un cartiglio (vd. foto), si contrappongono invece l’Albero della Vita e le colombe con l’ampolla, due modi per alludere alla resurrezione rispettivamente di Cristo e dei fedeli.
Gli incroci delineati non escludono tuttavia anche una lettura consequenziale di alcune parti, come sembra suggerire la giustapposizione della Vergine, del Battista e di Cristo, che fanno visivamente gruppo grazie al moltiplicarsi del gesto e alla presenza delle aureole, esclusiva di queste tre figure.
Stabilito che la chiave di lettura risiede nel codice gestuale, ecco spiegato come mai le forme siano così elementari, le mani così lunghe e le braccia così sproporzionate, caratteristiche tipiche di un
linguaggio che esagera volutamente alcuni particolari e ne semplifica altri per rendere espliciti i contenuti delle immagini. Nello specifico quello che emerge è un messaggio di salvezza costruito sul parallelismo tra la storia sacra e il suo riflettersi nel rito battesimale: poiché Cristo si era incarnato e si era fatto uomo (Annunciazione), era stato battezzato (Giovanni Battista) ed era morto e risorto per redimere l’umanità (Agnello sacrificale e Leone), ora i fedeli possono, grazie al Battesimo e all’insegnamento di Dio (Cristo con il libro e catecumeno), ripercorrere simbolicamente quelle tappe, rinascere liberi dal peccato e aspirare al Paradiso (Albero della Vita, colombe e ampolla).
Per quanto riguarda la datazione del fonte ancora oggi le informazioni turistiche riportano date che vanno dal periodo longobardo al XIII secolo. Tuttavia sappiamo bene che dal punto di vista stilistico forme come quelle scolpite nel fonte di Bazzano trovano confronti precisi tra XI e XII secolo nei cantieri del c.d. “romanico lombardo”. Dalla cattedrale di Parma al portale di Castel Tirolo, numerosi esempi portano a focalizzare la datazione tra l’ultimo quarto dell’XI secolo e la metà del XII. A conferma sono fondamentali gli abiti dei personaggi (che in origine dovevano essere colorati e ben leggibili): quello della Vergine, per esempio, è tipico delle signore di allora (vd. foto), mentre quello del catecumeno trova rispondenze, soprattutto nella foggia della cintura, sia nelle sculture dei centri citati che in molti altri del periodo. I motivi vegetali hanno invece lunga vita e derivano spesso dalla tradizione altomedievale. Alcuni tuttavia interessano maggiormente perché sembrano essere databili con più precisione: le palmette che si incastrano a formare l’arco sopra l’agnello (vd. foto), le ritroviamo sia a Parma che nel Parmense, in ambito Modenese e a Bologna, ma sempre in contesti databili tra XI e XII secolo.
Per quanto riguarda la datazione del fonte ancora oggi le informazioni turistiche riportano date che vanno dal periodo longobardo al XIII secolo. Tuttavia sappiamo bene che dal punto di vista stilistico forme come quelle scolpite nel fonte di Bazzano trovano confronti precisi tra XI e XII secolo nei cantieri del c.d. “romanico lombardo”. Dalla cattedrale di Parma al portale di Castel Tirolo, numerosi esempi portano a focalizzare la datazione tra l’ultimo quarto dell’XI secolo e la metà del XII. A conferma sono fondamentali gli abiti dei personaggi (che in origine dovevano essere colorati e ben leggibili): quello della Vergine, per esempio, è tipico delle signore di allora (vd. foto), mentre quello del catecumeno trova rispondenze, soprattutto nella foggia della cintura, sia nelle sculture dei centri citati che in molti altri del periodo. I motivi vegetali hanno invece lunga vita e derivano spesso dalla tradizione altomedievale. Alcuni tuttavia interessano maggiormente perché sembrano essere databili con più precisione: le palmette che si incastrano a formare l’arco sopra l’agnello (vd. foto), le ritroviamo sia a Parma che nel Parmense, in ambito Modenese e a Bologna, ma sempre in contesti databili tra XI e XII secolo.
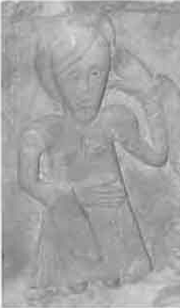


Stesso discorso per il tralcio che orna la sommità della vasca, caratterizzato da una particolare foglia che si piega su se stessa, esattamente come in quegli stessi anni a Parma, a Pavia e a Milano.
Allo stato attuale restringere al decennio la forbice temporale appare inutile e difficilmente dimostrabile; tuttavia indagini approfondite sui rapporti con l’ambiente culturale legato a Matilde di Canossa e con i cantieri della chiesa reggiana di Santo Stefano e della cattedrale di Parma, potranno aprire nuovi orizzonti di studio.
Allo stato attuale restringere al decennio la forbice temporale appare inutile e difficilmente dimostrabile; tuttavia indagini approfondite sui rapporti con l’ambiente culturale legato a Matilde di Canossa e con i cantieri della chiesa reggiana di Santo Stefano e della cattedrale di Parma, potranno aprire nuovi orizzonti di studio.
Dimensioni
Lati: 47-50 cm ca.
Altezza: 67 cm ca.
Diametro interno: 80 cm ca.
Profondità massima: 50 cm ca.
Lati: 47-50 cm ca.
Altezza: 67 cm ca.
Diametro interno: 80 cm ca.
Profondità massima: 50 cm ca.
Particolare del fonte battesimale: resa anatomica della vergine.
Particolare del fonte battesimale: palmette e agnello.
Particolare del fonte battesimale: catecumeno e leone.