GLI ARTICOLI SU MONTEPIANO
Anno 6° - Numero 68
SCULTURE ERRATICHE NEVIANESI 2
Campionario di testimonianze scolpite dal territorio di Neviano degli Arduini
di Alessandro Garbasi
Campionario di testimonianze scolpite dal territorio di Neviano degli Arduini
di Alessandro Garbasi

In questo numero di Monte Piano proseguiamo il nostro sorprendente viaggio alla scoperta delle testimonianze scolpite del territorio di Neviano degli Arduini, spesso sconosciute anche agli stessi abitanti del posto. Certamente, sul podio dei reperti scultorei più interessanti che l'antichità ci ha trasmesso, insieme ai fonti battesimali di Bazzano e Sasso, è l'architrave della Corte Mazzini di Scurano, enigmatico bassorilievo che presenta una complessa immagine che interseca simbologie criptiche e tradizioni popolari.
Da sinistra un coniglio, di cui si vedono solo la testa e la zampa anteriore, fa capolino, sembra, per mangiare il tralcio fiorito che gli sta dinnanzi. Sopra, una strana struttura che evoca i merli a coda di rondine di un edificio fortificato chiude la prima parte della scena.
Da destra un uccello con una curiosa "aureola" in testa (che evoca certe figure della religione egizia) sembra essere morto, sdraiato, si direbbe, su di un'ara sacrificale. Sotto e accanto a lui tre palle e un arbusto fiorito della specie di quello di sinistra, un astro rotondo in cielo, un'anomalia nella cornice dentellata che chiude in basso la composizione (si direbbe un' allusione a una voragine) e un uomo vestito con una tunica stretta in vita a braccia spalancate, nella tipica iconografia dell' orante, piuttosto diffusa nel Medioevo.
Al centro vi è il cuore della composizione, attorno a cui tutto ruota. Un medaglione centrale con fiore celtico crea una suddivisione spaziale esagonale: i due lati di sinistra sono occupati da due uccelli, così identificati per analogia con il disegno simile di un capitello della chiesa di Ranzano (Parma) e per il fatto che la medesima impostazione formale ritorna anche nei disegni dei bambini o di quegli artisti, come Gianfranco Asveri, che cercano di dipingere proprio con la libertà formale dei bambini. In senso orario troviamo un pesce, un altro uccello "aureo lato" con accanto un secondo volatile e un lupo o un cane (si notino il collare, i potenti artigli e i denti acuminati).
È molto complesso entrare nel merito della lettura di quest'immagine, che sembra evocare più una favola o una leggenda piuttosto che un passo della Scrittura.
Anche la datazione dell' opera è estremamente complessa, essendo le forme qui proposte senza tempo e patrimonio di quella cultura popolare che perdura nei secoli incurante dei progressi della storia dell'arte. Tuttavia, una datazione compresa tra il XIV e il XVI secolo potrebbe essere plausibile. Un'analisi muraria potrebbe ulteriormente definire il campo, dato che l'architrave non si trova verosimilmente nella sua posizione originaria ma è ben inserito nel contesto murario, il che induce a credere che sia stato collocato nell'attuale posizione in fase di costruzione del muro, muro che può essere oggetto di una datazione relativa. Da dove l'architrave provenisse non è dato sapersi, certo è che a Scurano, nelle vicinanze della corte, sorgeva il Castello, e siccome l'architrave è attribuibile a un contesto nobiliare, sebbene rimanga formalmente popolare, e siccome sembra adattarsi meglio a un contesto laico piuttosto che a uno ecclesiastico, si potrebbe immaginare la sua provenienza appunto dal Castello (se provenisse dalla medesima corte sarebbe forse rimasto nella parte più antica della stessa, nella sua posizione originaria senza essere spostato).
L’esagono, la rosa celtica e il coniglio possono essere simboli di resurrezione, l'uomo può essere in preghiera, l'uccello a destra sembra essere sacrificato, mentre prima lo troviamo nelle vicinanze del pesce, simbolo cristologico, e la voragine in terra può evocare la porta per l'Inferno, al contrario della resurrezione. In quest'atmosfera quasi metafisica la fiera ha il collare come se fosse addomesticata, magari del castello evocato dai merli di sinistra. Si tratta insomma di fragili congetture slegate tra di loro, ma che rendono l'enigma dell'architrave di Scurano ancor più intrigante e stimolante.
Altro bassorilievo di notevole interesse, che ci mantiene nell'atmosfera leggendaria e favolosa nonostante l'origine forse diversa dell'immagine, è quello che si trova in una delle pietre cantonali della Corte Zanetti di Lodrignano (oggi la pietra non è più angolare a causa dell'ampliamento del complesso). Nell'immagine, un uomo a piedi con un curioso copricapo segue un cavaliere che sembra impugnare una lancia nella destra e un arco nella sinistra. Si l'rana probabilmente di due guardie o due soldati, forse indicanti l'edificio che fungeva da loro sede a Lodrignano. Palazzo Zanetti, infatti, collocato attualmente di fronte alla chiesa, si trova sulla direttrice nord-sud che da Bazzano portava a Scurano. Siccome Bazzano e Scurano fino alla metà dell'Ottocento appartenevano al Ducato di Modena mentre Lodrignano apparteneva a quello di Parma, un presidio parmense doveva esserci proprio nei pressi del paese per controllare e scongiurare il contrabbando tra i due ducati. La pietra cantonale non presenta palesi segni di ricollocamento, ed è quindi associabile alla fase del Palazzo in cui ancora oggi la si trova, probabilmente del XVII secolo. Che siano due guardie è suggerito dai copricapi, probabilmente elmi, dal fatto che il cavallo, con sella e briglie, era un mezzo di trasporto non comune per i paesani, dalle armi e dalla posizione del Palazzo.
Il parroco di un tempo riteneva che l'immagine potesse essere longobarda, ma naturalmente il lessico formale, sebbene possa ricordare certi stilemi, non ha nulla a che vedere con periodi così remoti.
Da sinistra un coniglio, di cui si vedono solo la testa e la zampa anteriore, fa capolino, sembra, per mangiare il tralcio fiorito che gli sta dinnanzi. Sopra, una strana struttura che evoca i merli a coda di rondine di un edificio fortificato chiude la prima parte della scena.
Da destra un uccello con una curiosa "aureola" in testa (che evoca certe figure della religione egizia) sembra essere morto, sdraiato, si direbbe, su di un'ara sacrificale. Sotto e accanto a lui tre palle e un arbusto fiorito della specie di quello di sinistra, un astro rotondo in cielo, un'anomalia nella cornice dentellata che chiude in basso la composizione (si direbbe un' allusione a una voragine) e un uomo vestito con una tunica stretta in vita a braccia spalancate, nella tipica iconografia dell' orante, piuttosto diffusa nel Medioevo.
Al centro vi è il cuore della composizione, attorno a cui tutto ruota. Un medaglione centrale con fiore celtico crea una suddivisione spaziale esagonale: i due lati di sinistra sono occupati da due uccelli, così identificati per analogia con il disegno simile di un capitello della chiesa di Ranzano (Parma) e per il fatto che la medesima impostazione formale ritorna anche nei disegni dei bambini o di quegli artisti, come Gianfranco Asveri, che cercano di dipingere proprio con la libertà formale dei bambini. In senso orario troviamo un pesce, un altro uccello "aureo lato" con accanto un secondo volatile e un lupo o un cane (si notino il collare, i potenti artigli e i denti acuminati).
È molto complesso entrare nel merito della lettura di quest'immagine, che sembra evocare più una favola o una leggenda piuttosto che un passo della Scrittura.
Anche la datazione dell' opera è estremamente complessa, essendo le forme qui proposte senza tempo e patrimonio di quella cultura popolare che perdura nei secoli incurante dei progressi della storia dell'arte. Tuttavia, una datazione compresa tra il XIV e il XVI secolo potrebbe essere plausibile. Un'analisi muraria potrebbe ulteriormente definire il campo, dato che l'architrave non si trova verosimilmente nella sua posizione originaria ma è ben inserito nel contesto murario, il che induce a credere che sia stato collocato nell'attuale posizione in fase di costruzione del muro, muro che può essere oggetto di una datazione relativa. Da dove l'architrave provenisse non è dato sapersi, certo è che a Scurano, nelle vicinanze della corte, sorgeva il Castello, e siccome l'architrave è attribuibile a un contesto nobiliare, sebbene rimanga formalmente popolare, e siccome sembra adattarsi meglio a un contesto laico piuttosto che a uno ecclesiastico, si potrebbe immaginare la sua provenienza appunto dal Castello (se provenisse dalla medesima corte sarebbe forse rimasto nella parte più antica della stessa, nella sua posizione originaria senza essere spostato).
L’esagono, la rosa celtica e il coniglio possono essere simboli di resurrezione, l'uomo può essere in preghiera, l'uccello a destra sembra essere sacrificato, mentre prima lo troviamo nelle vicinanze del pesce, simbolo cristologico, e la voragine in terra può evocare la porta per l'Inferno, al contrario della resurrezione. In quest'atmosfera quasi metafisica la fiera ha il collare come se fosse addomesticata, magari del castello evocato dai merli di sinistra. Si tratta insomma di fragili congetture slegate tra di loro, ma che rendono l'enigma dell'architrave di Scurano ancor più intrigante e stimolante.
Altro bassorilievo di notevole interesse, che ci mantiene nell'atmosfera leggendaria e favolosa nonostante l'origine forse diversa dell'immagine, è quello che si trova in una delle pietre cantonali della Corte Zanetti di Lodrignano (oggi la pietra non è più angolare a causa dell'ampliamento del complesso). Nell'immagine, un uomo a piedi con un curioso copricapo segue un cavaliere che sembra impugnare una lancia nella destra e un arco nella sinistra. Si l'rana probabilmente di due guardie o due soldati, forse indicanti l'edificio che fungeva da loro sede a Lodrignano. Palazzo Zanetti, infatti, collocato attualmente di fronte alla chiesa, si trova sulla direttrice nord-sud che da Bazzano portava a Scurano. Siccome Bazzano e Scurano fino alla metà dell'Ottocento appartenevano al Ducato di Modena mentre Lodrignano apparteneva a quello di Parma, un presidio parmense doveva esserci proprio nei pressi del paese per controllare e scongiurare il contrabbando tra i due ducati. La pietra cantonale non presenta palesi segni di ricollocamento, ed è quindi associabile alla fase del Palazzo in cui ancora oggi la si trova, probabilmente del XVII secolo. Che siano due guardie è suggerito dai copricapi, probabilmente elmi, dal fatto che il cavallo, con sella e briglie, era un mezzo di trasporto non comune per i paesani, dalle armi e dalla posizione del Palazzo.
Il parroco di un tempo riteneva che l'immagine potesse essere longobarda, ma naturalmente il lessico formale, sebbene possa ricordare certi stilemi, non ha nulla a che vedere con periodi così remoti.


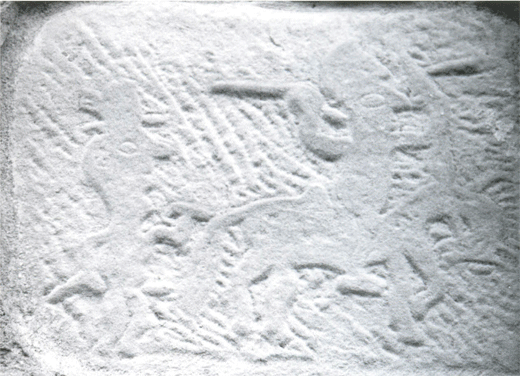
"Siccome Bazzano
e Scurano
fino alla metà
dell 'Ottocento
appartenevano
al Ducato di
Modena mentre
Lodrignano
apparteneva a
quello di Parma,
un presidio
parmense doveva
esserci proprio nei
pressi del paese
per controllare
e scongiurare il
contrabbando tra i
due ducati".
e Scurano
fino alla metà
dell 'Ottocento
appartenevano
al Ducato di
Modena mentre
Lodrignano
apparteneva a
quello di Parma,
un presidio
parmense doveva
esserci proprio nei
pressi del paese
per controllare
e scongiurare il
contrabbando tra i
due ducati".
Sul lato strada del Palazzo, in un'ala decisamente più recente, forse ottocentesca, una seconda immagine attira l'attenzione. Si tratta di un rilievo più pronunciato del primo e di fattura più grezza, con un uomo che a fatica porta un sacco sulle spalle con davanti un secondo individuo che con il braccio sembra incitare il primo a procedere. Le forme sono essenziali come parte della scultura medievale e
quasi tutta la scultura di matrice popolare. Anche in questo caso possiamo provare a leggere la scultura attraverso la presumibile storia del Palazzo, proponendo di vedere l'uomo con il sacco come il contrabbandiere che tenta di passare abusivamente con il suo sacco pieno di derrate o di sale nel ducato di Parma (la via che costeggia l'edificio e su cui si affaccia la scultura era una via del sale) e l'altro come la guardia che lo intercetta, oppure come una sorta di indicazione stradale che indica proprio la Via del Sale. La pietra, anche questa volta cantonale, è più recente dell' altra, forse settecentesca o ottocentesca.
Una situazione assimilabile la si ritrova a Lupazzano, simile per la presenza di un importante edificio a presidio di una strada che probabilmente una volta entrava da quel punto in paese, sebbene muti il tenore delle due immagini canronali. Nella prima, un uomo frontale a braccia aperte sembra affrontare un uccello dalla lunga coda, un gallo si direbbe. Il pennuto, in atteggiamento minaccioso data anche la dimensione, è reso a incisione, a differenza dell'uomo che è a bassorilievo.
Una situazione assimilabile la si ritrova a Lupazzano, simile per la presenza di un importante edificio a presidio di una strada che probabilmente una volta entrava da quel punto in paese, sebbene muti il tenore delle due immagini canronali. Nella prima, un uomo frontale a braccia aperte sembra affrontare un uccello dalla lunga coda, un gallo si direbbe. Il pennuto, in atteggiamento minaccioso data anche la dimensione, è reso a incisione, a differenza dell'uomo che è a bassorilievo.
Nell' altra si vedono due personaggi che si tengono l'un l'altro per un braccio, che hanno ormai perduto alcune parti che ne pregiudicano la lettura. Il primo uomo, che ha perso il volto, alza il braccio destro in segno, si direbbe, di saluto, mentre il secondo, che lo tiene per i braccio, ha perduto la parte centrale del corpo. Nessun ulteriore elemento emerge con chiarezza. Entrambe le figure sono collocate all' estrema sinistra della pietra, in prossimità dell'angolo del Palazzo. La pietra con l'uomo e il gallo si trova appena al di sotto, sul muro della torre, dell'altra con le due figure adiacenti. Entrambe le immagini erano rivolte verso l'interno del paese ed erano pertanto apprezzabili uscendo dallo stesso. Anche in questo caso siamo circa nel XVII secolo.
In alto: l'architrave colpito
della Corte Mazzini di Scurano.
Sotto: pietra angolare della
Corte Boselli a Lupazzano.
della Corte Mazzini di Scurano.
Sotto: pietra angolare della
Corte Boselli a Lupazzano.
Sopra: Un'altra significativa pietra angolare della Corte Boselli di Lupazzano.
Sotto:
L'interessante affigurazione
che spicca su una pietra
angolare della Corte Zanetti a
Lodrignano.
Sotto:
L'interessante affigurazione
che spicca su una pietra
angolare della Corte Zanetti a
Lodrignano.